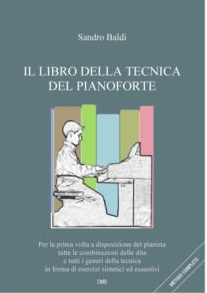SANDRO BALDI IL LIBRO DELLA TECNICA DEL PIANOFORTE EDIZIONE COMPLETA METODO LIBRO PER PIANOFORTE
€32,00
+ PreferitiDescrizione
Indice Completo
I Generi della tecnica
PRIMO GENERE
Le combinazioni con le cinque dita
Le 5 combinazioni con un dito alla volta
Le 10 combinazioni con due dita alla volta
Le 12 posizioni delle cinque dita con gli accordi
I diversi tipi di tocco di dito
Esercizio cromatico per l’indipendenza del 3°, 4° e 5° dito
Le 50 combinazioni con tre dita alla volta
SECONDO GENERE
Le scale
Scale maggiori e minori
Scala cromatica e scala esatonale
Modi di studio delle scale
Scala per moto retto, per terza, per sesta e per moto contrario
Scala in velocità e con le varianti ritmiche
Scale in doppie terze
Scale in doppie seste
TERZO GENERE
Gli arpeggi
Arpeggi maggiori e minori
Arpeggi di settima di dominante e di settima diminuita
Appendici
I) Rivolti delle triadi maggiori, minori, diminuite ed eccedenti
II) Altri tipi di tocco
III) Schemi ritmici
IV) Schema degli intervalli melodici
Parte II
QUARTO GENERE
Note doppie
Le ottave – esercizio preparatorio
Le ottave legate sulla scala cromatica
Le ottave sulle scale diatoniche
Le ottave sulle settime diminuite
Le ottave sugli accordi maggiori e minori
Le doppie terze sugli accordi minori e maggiori
Le 10 combinazioni in doppie note (due dita alla volta)
Le 15 combinazioni in doppie note (quattro dita alla volta)
La scala cromatica sulle doppie terze e doppie seste minori
QUINTO GENERE
Tecnica varia
Ribattuti
Glissandi
Salti
Incroci
Sostituzione di un dito
Polifonia
Poliritmia
Estensioni
Pedalizzazione
Appendici
I) Metodo di studio
II) Diteggiatura
III) Memorizzazione
IV) Abbellimenti (in J. S. Bach e D. Scarlatti)
V) Moduli di tecnica in forma di esercizi riassuntivi
__________________________________________
ESTRATTO: IL SECONDO GENERE DELLA TECNICA: LE SCALE
… giunti a questo punto, possiamo considerare le scale come il naturale compimento di un percorso che, attraverso gli esercizi di elasticità e di coordinazione delle dita, mira a costruire la tecnica pianistica su basi razionali e complete.
Vi sono ovviamente molti modi di eseguire le scale, che dipendono non solo dalla velocità ma anche dal tipo di tocco e dai movimenti della mano. Nei primi due casi si tratta di elementi collegati, nel senso che a movimenti delle dita molto articolati corrisponderà, il più delle volte, una velocità limitata, e viceversa; nel caso invece dei movimenti della mano si osserva una diversità di vedute che oppone fra loro scuole diverse.
Il punto critico è soprattutto rappresentato dal movimento del pollice (il passaggio del pollice è uno dei movimenti essenziali nell’esecuzione di una scala), dito che alcuni suggeriscono di articolare in senso verticale e di mantenere “affiancato alla mano” (Sandor, pp. 99 e 104), con il polso lievemente alzato (e poi abbassato di nuovo quando si usa il pollice) e il gomito un po’ scostato dal corpo. Altri invece considerano il pollice dotato di una maggiore indipendenza e suggeriscono di muoverlo anche in senso orizzontale: articolando il dito sotto il palmo, si eserciterebbe la mano a una maggiore elasticità e si otterrebbe un vantaggio nella velocità di esecuzione. In estrema sintesi, in un caso la mano descriverebbe, nell’eseguire la scala, una sorta di armonico ondeggiamento, nell’altro essa manterrebbe una compostezza e un andamento più rettilineo e uniforme.
Per rifarci a didatti che in tempi abbastanza recenti hanno lasciato un’impronta profonda nel campo del pianoforte, si può dire che Gyorgy Sandor esprima la prima posizione, cioè con un aggiustamento laterale della mano e il pollice articolato in verticale (pp. 104-105), movimento adatto a un’esecuzione ben legata e non troppo veloce; mentre Heinrich Neuhaus, il maestro di Richter e Gilels, la seconda. Per quest’ultimo il pollice va preparato sotto il palmo immediatamente dopo aver suonato il secondo dito “come si trattasse di un’acciaccatura” (p. 168): appaiono evidenti le affinità con Alfred Cortot, che ci offre un esempio chiarissimo dell’anticipazione del pollice sulla nota che esso dovrà suonare (p. 31), e più alla lontana con Franz Liszt ( quaderno II, esercizi n. 10 e n. 11, p. 68). Per la flessibilità del pollice sotto il palmo della mano sia Cortot (esercizio n. 1, p. 30) che Hanon (esercizio n. 37, p. 52) offrono utili esempi.
Da parte nostra riteniamo che il robusto muscolo del pollice, messo sotto sforzo ma non stressato, offra il giusto supporto per il lavoro richiesto a questo importante dito della mano: un adeguato esercizio del pollice mette cioè la mano nella condizione di eseguire con la massima sicurezza le molteplici e spesso scomode figurazioni che la letteratura pianistica ci mette ogni giorno davanti.